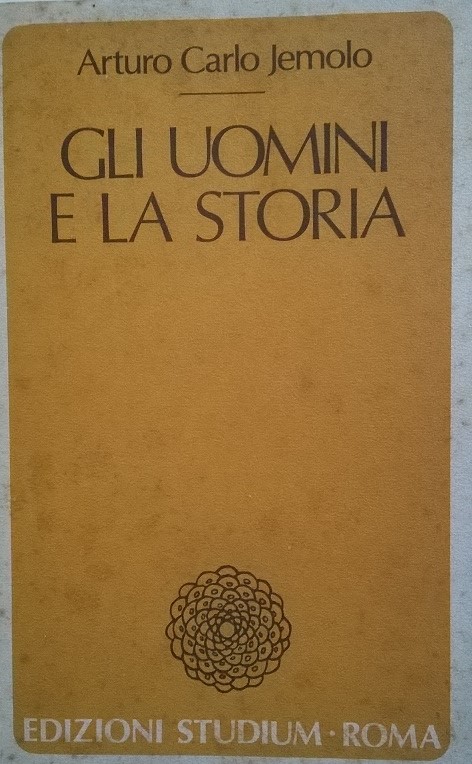di Arturo Carlo Jemolo – «La Stampa», 13 luglio 1969
Finito l’anno del Cinquantenario continuano le pubblicazioni sulla prima «grande guerra»; è una letteratura lungi dall’esaurirsi, ché sempre più emerge la coscienza che quella guerra segnò la chiusura di un’epoca, la fine della posizione egemonica dell’Europa, la crisi dei valori umani e politici che si erano affermati dall’illuminismo al liberalismo.
Per quel che tocca l’Italia, sono comparsi quasi contemporaneamente il volume di Piero Melograni, Storia politica della grande guerra (ed. Laterza), la traduzione italiana dell’opera di John A. Thayer, L’Italia e la grande guerra (ed. Vallecchi) e Il diario di Salandra a cura di G. B. Gifuni (ed. Pan).
Nel volume del Melograni è molto bene messa in risalto la contrapposizione tra la psicologia della massa dei soldati, eminentemente dei fanti (tratti nella quasi totalità dalle classi rurali, in anni in cui ancora l’analfabetismo abbonda, la lettura dei giornali è molto rara tra i contadini: sottoposti così a sofferenze, fatiche senza nome, decimati nelle offensive, senza poter accedere agli entusiasmi o alle illusioni che confortano il sacrificio dei volontari, tutti di appartenenza borghese), e quella dei capi militari, per cui questo tipo di guerra era una cosa nuova (ma molti non avevano mai visto guerre), e che ritenevano non si desse limite in ciò che si poteva esigere dai soldati.
C’è il contrasto altresì tra ufficiali effettivi ed ufficiali di complemento; tra ufficiali di complemento che per nascita, o perché già affermatisi nella vita civile, erano stati chiamati presso comandi o in uffici di propaganda, ed i loro colleghi sempre rimasti fra le truppe; il disagio dei politici intimiditi dalla possente personalità di Cadorna, che non riconosceva la superiorità del governo, non voleva controlli né pretese di informazioni. Appare altresì l’ossessione degli uomini politici che più avevano spinto all’intervento, smarriti di fronte agli enormi ed imprevisti sacrifici, al numero dei caduti e dei mutilati, terrorizzati all’idea di quella che sarebbe stata la reazione popolare ad una pace di compromesso, che non ci avesse dato Trento e Trieste.
È una storia del tutto diversa, antitetica a quella degli scritti del tempo e degli anni immediatamente di poi, alla storia apologetica, con il popolo che vibra come un sol uomo di odio al tedesco, di desiderio di resistere sino alla fine.
Il libro del Thayer prende le mosse dal 1870, ed anche rispetto agli anni 1915-’18 dà posto alle preoccupazioni dell’Italia per le possibili rivendicazioni della Santa Sede al momento della pace: che portarono alla inclusione di un apposito articolo nel trattato di Londra, considerato un errore.
Il diario di Salandra non dice cose nuove: acredine e non finire verso Giolitti, ma anche malevolenza verso Orlando e Nitti; conferma della mancanza di ogni duttilità in Sonnino, incomprensione assoluta di questi verso l’Europa che nascerà dalla guerra, verso il posto che avranno i popoli slavi, verso le nuove Nazioni che sorgeranno e che bisognerebbe assicurare amiche all’Italia. Di qualche maggiore interesse le pagine del diario relative al decennio che segue il termine della guerra, alla crisi dopo il delitto Matteotti.
Chi legga tutte queste pagine a tanti anni di distanza, spenta ormai ogni passione, ne trae il senso della vanità di ogni dottrina che creda di poter razionalizzare la storia, trovare la causa degli eventi in squilibri di classi o ragioni economiche; gli risuona piuttosto all’orecchio il vecchio detto che Dio toglie il senno a coloro che vuole perdere. Come si poteva nella primavera del ’15 pensare che la guerra sarebbe finita al sopravvenire dell’autunno?
C’è da ridere, per non piangere, nel ricordare che il segno che l’Italia stava per entrare in guerra fu dato dall’ordine di abbrunire le sciabole degli ufficiali e relativi foderi; si era al decimo mese della guerra europea, ed a Roma ancora si pensava che gli ufficiali levassero al cielo la sciabola per condurre al fuoco i soldati.
Accecamento generale; ma chi si salva? Neppure quelli che ciechi non furono nel prevedere la durata della guerra, la somma dei sacrifici, la svalutazione della lira, il colpo a tutte le vecchie strutture. Giolitti e Nitti vedevano con sufficiente chiarezza; ma Giolitti preferì – nell’inverno e primavera tra il ’14 e il ’15 – di riservarsi, essere discreto, stare lontano da Roma, allorché sarebbe occorso dare ogni sforzo per riprendere in mano le redini del governo, come fa il cocchiere smontato che vede il cavallo avviarsi al trotto verso il burrone.
Responsabilità massiccia di Salandra che lascia scatenare le passioni politiche (non consta ci fosse, appena noto l’ultimatum alla Serbia, l’appello a tutti i direttori di giornali, uomini d’ordine, Albertini per primo, di non prendere posizione, non ostacolare l’opera del governo), e crede di cavalcare la tigre, pieno di sé. Il re assennatamente il 9 maggio gli dice che è bene vedere Giolitti che viene a Roma, intendersi con lui; e Salandra risponde che mai avrebbe fatto il presidente sotto il protettorato di Giolitti, come Luzzatti e Fortis.
Salandra nel diario parla molto della benevolenza del re per lui: «Che gran brav’uomo è lei!» gli dice Vittorio Emanuele; Salandra non sospetta che ci possa essere un’ombra di malizia in quelle parole. Il re dice di essere pronto ad andarsene col figlio, lasciando il regno al duca d’Aosta; parlerà sul serio? Espertissimo in cose dinastiche, ben sa che un re non può impegnare i discendenti; si dovrebbe pensare ad un piano mefistofelico per dare all’inviso cugino un regno dalla legittimità sempre contestata?
Più interessano gli accenni che sono nel libro del Melograni – e si tratta di cosa di cui spesso si è parlato – ad un colpo di Stato da effettuare con l’aiuto dell’esercito, partecipe Cadorna, ventilato nella primavera e nell’estate del ’17: follia pura, fare di tutto il neutralismo il difensore della Costituzione, eccitare reggimenti (ci sono intere brigate di cui si dubita) a lasciare il fronte per venire a difendere lo Statuto.
Sull’intervento duro giudizio del Thayer: l’Italia era unita nei mesi della neutralità; Nord e Sud, Chiesa e Stato, Camera e popolo volevano la pace; e questa saggezza era il successo del post-Risorgimento; le giornate di maggio furono la vittoria dell’anarchia intellettuale, del giornalismo dannunziano ed insegnarono a Mussolini i metodi della sovversione. Mancava ogni giustificazione utilistica e razionalistica; l’intervento fu «un atto di follia politica e diplomatica, il trionfo dell’irrazionalismo». Ma l’autore non può ignorare quanto pur nel suo Paese i miti, le repulsioni irrazionali ostacolino la vittoria della ragione.
Nel libro del Melograni interessante anche la pagina finale; dopo l’armistizio Orlando vieta la pubblicazione di un comunicato del Comando Supremo sulle condizioni dell’esercito austriaco, sui molti morti nella ritirata, sull’assalto di treni da parte di soldati austriaci affamati. Orlando teme che l’immagine dei morti alimenti la reazione contro la guerra, che gli assalti di soldati affamati eccitino pensieri di anarchia, che lo sfacelo dell’esercito austriaco diminuisca agli occhi del mondo l’importanza della vittoria italiana. Conclude l’autore: la vittoria «mutilata» era già nell’aria prima di Versailles.
È tutta una storia che potrebbe intitolarsi «la disfatta della ragione». Non la prima, non l’ultima: è il nesso che mi fa unire lo scoppio della prima guerra mondiale alle cronache sulla contestazione.