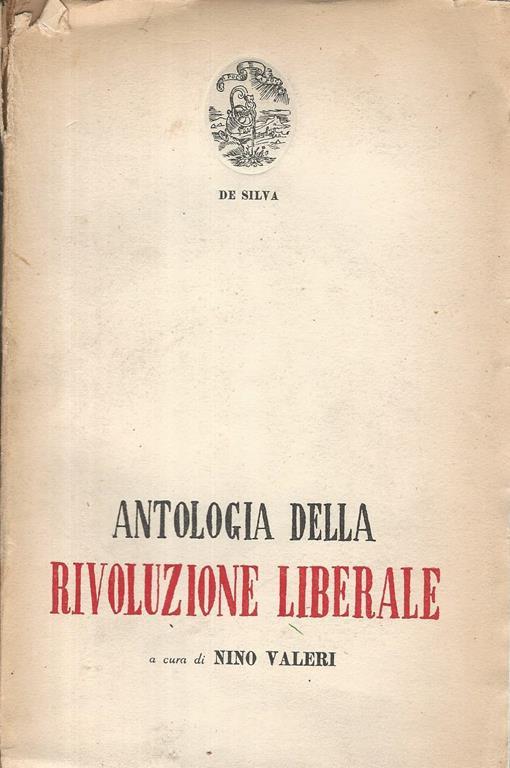di Giovanni Spadolini – «Il Messaggero», 15 maggio 1948
Un’esperienza, insieme politica, culturale e spirituale, che un po’ è la somma e la sintesi di tutte le altre che l’avevano preceduta e di ognuna ritiene e rinnega qualcosa, è quella che fece capo per quasi tre anni, dal 1922 al 1925, alla rivista diretta da Piero Gobetti, «La Rivoluzione liberale».
V’era nel titolo di quella rivista, fondata da un giovane ventunenne pallido, sottile, malaticcio, tutto bruciato da una febbre di ricerca intellettuale, tutto consumato da un ardore d’ispirazione morale, v’era, dico, in quel titolo un senso insieme di amarezza, di nostalgia e di speranza.
Di amarezza, in quanto Gobetti ben sapeva che un’autentica rivoluzione liberale era mancata al popolo italiano, e tutte le insufficienze dell’Italia contemporanea e le sue contraddizioni e la sua incapacità a risolvere gli antichi problemi e il suo oscillare fra soluzioni di forza e ripieghi di debolezza e quel rinascere di miti vecchi e retorici e quel rimpaludarsi nei compromessi tradizionali, tutto, insomma, il quadro dell’Italia 1920-’22 era una conseguenza del Risorgimento.
Di nostalgia, in quanto, di fronte al nuovo autoritarismo fascista sembrava che il liberalismo di Cavour fosse stato il punto più alto dell’esperienza ottocentesca, e tornava d’attualità lo stesso liberalismo pur così moderato e limitato dei piemontesi, i Santarosa, i Botta, gli Ornato, i Provana quelli della «Accademia dei Concordi» e gli alfieriani in ritardo, e proprio a loro Gobetti dedicava un suo libro fervido e commosso, pur nel suo titolo, così freddo, «Risorgimento senza eroi». E infine di speranza, perché, pur nell’oscillazione fra il disgusto dell’oggi e il risorgimento dell’ieri, fermo restava un punto: e cioè che bisognava a ogni costo, con tutti i mezzi, combattere, lottare, operare per il rinnovamento dell’Italia, per la trasformazione del popolo italiano.
Le basi della critica della società italiana eran già state poste prima di Gobetti; e spesso proprio da quei movimenti che presero nome dal Regno, dall’Unità, da Poesia, dalla Voce, da Lacerba.
In tal senso, Gobetti non compieva un’opera originale. Egli, con spirito critico, con senso di uomo nuovo, di uomo moderno, riprendeva gli argomenti che eran stati proposti da Croce, da Salvemini, da Gentile, da Einaudi, da Fortunato, da Missiroli, da Prezzolini, ed eran stati riaffermati un po’ da tutti i movimenti eretici o eterodossi del primo Novecento, dai sindacalisti, dai nazionalisti dissidenti, dai giovani liberali, dai repubblicani, dai socialisti indipendenti.
Non nuova era la «critica della democrazia»; non nuova la «critica del parlamentarismo»; non nuova la «critica del protezionismo»; non nuova l’affermazione della mancata rivoluzione religiosa in Italia, che, insieme a molte altre, si riallacciava al filone della corrente clericale italiana, e risaliva anche al sempre vivo Oriani.
Non nuova la automia delle insufficienze del Risorgimento, a cui appunto la storiografia «irregolare» di tipo orianesco s’era già accinta ed era stata in parte accettata anche dalla storiografia «ortodossa»; non dimentichiamoci che Oriani era stato fatto conoscere agli italiani da Benedetto Croce.
Ma tutto ciò non implica che la varia e viva opera di Gobetti e del suo gruppo si riducesse, come qualcuno ha di recente affermato, a «un riecheggiamento», di altri pensatori. Quelli di «Rivoluzione liberale» non riecheggiarono, non ripeterono, ma risentirono, ma rivissero molti dei problemi comuni alla generazione precedente e trasmessi alla nuova insoluti e anzi inaspriti.
Quali erano quei problemi? Uno li sovrastava e riassumeva tutti: era l’antico problema mazziniano dell’«iniziativa spirituale e politica». Si ha un bel dire che in questo senso Gobetti era vittima di Sorel o di Oriani o di D’Annunzio o addirittura succube del clima eroicistico, irrazionalistico, attivistico degli anni intorno alla guerra. Ammesso anche, che vivendo nel suo tempo, Gobetti lo vivesse in pieno, il problema non viene spostato d’una virgola: esso sussiste in tutta la sua crudezza.
L’Italia era gravata da quel senso del compromesso, della transazione, dell’equivoco, che era stato il connotato peculiare del suo Risorgimento. Fu gran merito di quel gruppo aver affermato che un rinnovamento ideale e istituzionale dell’Italia poteva seguire solo a una ripresa di iniziative autonome, singolari, molteplici; fu gran merito di quel gruppo aver posto delle esigenze di libertà, di nuova operante libertà, nel quadro di un liberalismo dinamico e drammatico, tale da sembrar, più che politica, religione, aspra, dura, intransigente religione.
Rileggendo proprio in questi giorni alcune delle pagine più importanti di quella rivista nella bella «Antologia della Rivoluzione liberale» che è stata curata da un acuto critico, Nino Valeri (De Silva, ed.), ci è venuto fatto di pensare che anche l’eclettismo politico del movimento ed anche, se volete, la diversità e l’eterogeneità dei suoi collaboratori erano un segno di quello spirito di libertà, di estrema, radicale, disperata libertà.
Uomini che poi ebbero sorti diverse, si ritrovarono su quel foglio a combattere una battaglia che aveva certo un senso, ed era un senso originale. Era la battaglia per creare l’Italia nuova, la nuova classe dirigente italiana, in uno spirito di «problemismo» polemico e critico.
Quella battaglia non fu vinta allora; ma non si creda che essa sia oggi perduta del tutto.